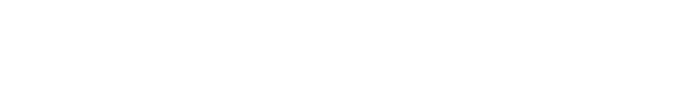Oggi 408 visitatori
-
FILM IMPERDIBILE

UNPLANNED
La vera storia di Abby Johnson
Ex dirigente di una clinica per aborti di Planned Parenthood -

STORIE VERE
Tutto sull'aborto
21 video straordinari -

DONA IL 5 X MILLE
AL CAV DI SIENA
Una firma che non ti costa nulla e che aiuta i bambini a nascere! -

COS'E'
Dal 2005 a difesa dei principi non negoziabili!
SCIENZA & VITA? -

ABORTO
Video sconvolgente
IN DIRETTA
Sconsigliato ad un pubblico sensibile
« Torna alla edizione
 LA SCELTA DI MORIRE NON E' LIBERA
LA SCELTA DI MORIRE NON E' LIBERA
Il 24 settembre u.s. la Corte Costituzionale ha sancito che l'aiuto al suicidio, contemplato dall'art. 580 del codice penale che prevede pene tra i 5 e i 12 anni di carcere, può non essere punibile a «determinate condizioni», nel caso di un «paziente affetto da una patologia irreversibile che gli causa sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale ma in grado di prendere decisioni consapevoli».
Le reazioni a questa sentenza sono state numerose e variegate, creando il consueto confronto tra i favorevoli e i contrari. In questa occasione però la questione dell'eutanasia e del fine vita si sono spostate ad un livello più «avanzato». Si è osservato come la Corte Costituzionale abbia legato la sentenza alla Legge 219/2017 («Disposizioni anticipate di Trattamento») a conferma che già allora l'impostazione di quel testo era squisitamente pro-eutanasica, anche se «ammorbidita» da questioni diverse quali il consenso informato, l'autodeterminazione del paziente, la condivisione del percorso di cure, ecc. Si è voluto procedere a tappe per introdurre in Italia il «diritto a morire», attraverso norme giuridiche che si presentassero come umane, eque, solidali e realmente vicine alle persone che soffrono. La Consulta ha, di fatto, aperto la questione della legalizzazione dell'eutanasia. Anche in questo caso, assistiamo a definizioni non sempre precise con lo scopo di confondere i termini reali da utilizzare. Ad esempio, l'EPAC (Associazione Europea dei Medici) distingue l'eutanasia, momento in cui un medico somministra una sostanza letale su richiesta del paziente, dal suicidio assistito, quando il medico aiuta il paziente a suicidarsi, lasciando però a lui la responsabilità dell'atto finale. Quindi, secondo queste definizioni, si tratterebbe di una questione «tecnica», in cui, nel secondo caso, il medico sarebbe deresponsabilizzato e avrebbe solo il compito di sorvegliare le modalità dell'atto suicidiario.
La Consulta ha utilizzato i termini «sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili» come motivazione per ricorrere al suicidio, spingendo e ipertrofizzando l'autodeterminazione del paziente che potrà così decidere di farla finita anche sulla base di una malattia psichica, di uno stato d'animo esistenziale negativo o di semplice mancanza di motivazioni di vivere. Basti ricordare alcuni recenti esempi: Noa Pothoven morta il 2 giugno in Olanda per grave depressione o Alan Nichols morto in Canada per lo stesso motivo, utilizzando il suicidio assistito.
L'aspetto su cui vorrei soffermarmi è però quello della «libertà di scelta». L'on. Cappato, dopo la sentenza, si è espresso con grande entusiasmo ed enfasi, sottolineando che «ora finalmente siamo liberi». Del resto, l'obiezione, mossa ogni volta che vengono approvate queste leggi, è la stessa: si deve essere liberi di scegliere se suicidarsi o meno, se utilizzare le DAT o meno, se abortire o meno. Lo Stato deve lasciare la possibilità di avvalersi di questi diritti. A parte l'immediata risposta che ci ricorda che alcune leggi (obbligo del casco o della cintura di sicurezza, ad esempio) sono state create limitando la libertà di scelta per il bene degli individui, ve ne è un'altra che fa riferimento alla «esperienza storica» di altri paesi (Olanda e Belgio, ad esempio) che da anni hanno adottato e utilizzato l'eutanasia e il suicidio assistito, fornendoci dati molto interessanti. Non esiste vera libertà di scelta in un ambiente culturale che pesantemente fa percepire la sofferenza, la malattia e la morte come assolutamente negative e in cui la dignità della vita sia definita esclusivamente secondo criteri utilitaristici («se io sto bene, sono attivo, funziono bene, mi relaziono bene, allora valgo»). Chi stabilisce il livello di dignità (con quale scala di valori) al di sotto del quale la vita non ha più senso? Ognuno per sé, sganciato dalla realtà oggettiva e dalla società, fatta di relazioni? E' chiaro che, con queste premesse, il parametro dignità della vita potrebbe subire continue e imprevedibili variazioni e mutazioni, non inquadrabili né misurabili dalla giurisprudenza o dalla medicina.
I fautori di queste leggi poi sostengono che il malato è consapevole e consenziente. Ma le esperienze dei Paesi appena ricordati evidenziano una percentuale non trascurabile di fraintendimenti o persino di mancato consenso, tanto da suscitare reazioni o denunce (a volte vere e proprie inchieste giudiziarie) da parte dei familiari e dei cari del defunto, evidenziando così un Sistema eutanasico che non desidera essere messo in discussione. Gli esempi di questa impostazione quasi «coercitiva» sono numerosi. Cito Joseph Fletcher e Granville Williams che negli anni '50, in area linguistica anglosassone, elaborarono il principio etico e giuridico del Right-to-Die e si resero sostenitori anche dell'uccisione non richiesta di soggetti portatori di gravi disfunzioni biologiche, per motivi eugenetici ed umanitari, soprattutto fra i bambini. Essi sostenevano tale diritto contro la mentalità religiosa espressa in particolare dalla Chiesa Cattolica.
Queste scelte potrebbero inoltre nascondere motivi economici. Come non pensare ad un progetto su ampia scala di riduzione della spesa sanitaria di fonte ad una popolazione sempre più anziana ed improduttiva?
La Medicina, nata per curare e guarire, come dovrà comportarsi? Dovrà rinnegare la sua essenza più profonda, la sua primaria funzione? Questa mentalità eutanasica infatti considera i malati gravi come «perduti», non degni di vivere e non meritevoli di ulteriori sforzi terapeutici, portando gradualmente a rinunciare a quella «ostinata» ricerca delle novità di cura anche ai casi più disperati, eliminando il tradizionale slancio medico verso studi sempre più complessi e, inevitabilmente, costosi.
Va ricordato infine che i malati sono fragili e che risentono del «clima culturale» che li circonda. E' come il fenomeno dei suicidi «a grappolo» (studiato in Psichiatria): uno inizia, altri lo seguono per un meccanismo di emulazione. Chi ci dice che, ora che si è aperta questa breccia, non potrà accadere lo stesso? E' ovvio che i pazienti, in questo clima di scoramento e di sfiducia, saranno «liberi» di scegliere solo la morte, quasi per togliersi di mezzo, eliminare il loro disturbo, la loro presenza avvertita come ingombrante, convinti peraltro che questa scelta sia libera e rappresenti un bene per loro e per la società e che soprattutto sia l'unica opzione possibile.
Per concludere, mi sembra che queste leggi così disumane portino con sé due conseguenze: la perdita della speranza e la solitudine degli individui. Nel primo caso, i malati si sentiranno inutili, senza uno scopo del loro vivere, privati di ogni prospettiva e aspirazione futura. Nel secondo caso, la tanto enfatizzata autodeterminazione, se esasperata, può condurre l'individuo a sentirsi sempre più solo, privato dell'esperienza delle relazioni e di una reale condivisione della malattia e della morte, avvertite come un'esperienza personale, chiusa in una rigida privacy, dentro una stanza senza porte o finestre comunicative.
Il Fatto Cristiano è l'unico che da senso e risposta a questi interrogativi: chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Perché soffro? Perché muoio? Solo Cristo è stato capace di glorificare la sofferenza e il dolore e di vincere, una volta per sempre, la Morte.
 Aborto
Aborto Animalismo
Animalismo Attualità
Attualità Covid-19
Covid-19 Eutanasia
Eutanasia Fecond. Artif.
Fecond. Artif. Matrimonio
Matrimonio Morale
Morale Omosessualità
Omosessualità Pedofilia
Pedofilia Pillole
Pillole Scienza
Scienza
-
PRIVACY
Informativa completa -
COS'E' SCIENZA & VITA?
Difendiamo i princìpi -
CONSIGLIO DIRETTIVO
Eletto dall'assemblea dei soci -
ABORTO IN DIRETTA
Video sconvolgente -
HAI ABORTITO?
Una parola di conforto -
PILLOLA DEI 5 GIORNI DOPO
Un video spiega che è abortiva -
TESTAMENTO BIOLOGICO
La legge sulle DAT ci preoccupa -
SEPPELLIRE IL PROPRIO BAMBINO NATO MORTO
Anche a Siena: vedi come -
CONFERENZE PROSSIME
Incontri in programma -
ARCHIVIO CONFERENZE
Elenco degli incontri organizzati -
ARCHIVIO ARTICOLI
Articoli di bioetica -
SITI AMICI
Alleati di Scienza & Vita -
VUOI AIUTARCI?
Fai una donazione libera -
HAI UNA DOMANDA?
Oppure un consiglio da darci...